Concetto Marchesi, il rettore che cacciò i fascisti dal Bo
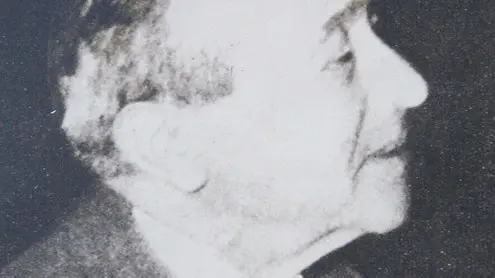
PADOVA. Nato nel 1878 a Catania, Concetto Marchesi aderisce giovanissimo alle correnti più estreme della democrazia radicale caratterizzate da una fede scientista e materialista che, nello specifico siciliano ed italiano, supporta un anticlericalismo profondo. Da queste premesse che spesso riemergeranno anche in età matura ed avanzata - Marchesi non condividerà la scelta tutta tattica di Togliatti di recepire, all’interno della Costituzione Repubblicana, i Patti Lateranensi come fondamento dei rapporti fra Stato e Chiesa Cattolica - il giovane Concetto muove per aderire, verso la fine del XIX secolo, al neonato Partito Socialista Italiano. Laureatosi a Catania Marchesi inizia ad insegnare nelle scuole superiori: è in Sicilia, a Verona, a Pisa e consegue la Libera Docenza in Letteratura Latina nel 1915: ha così inizio la sua lunga carriera universitaria che, dopo un primo periodo messinese, lo porta , a partire dal 1923, a insegnare Latino all’università di Padova.
Al Bo Marchesi sarà legatissimo e le migliaia di giovani che a Padova l’università hanno frequentato - e non solo nella facoltà di Lettere- nel periodo fascista - subiranno fortemente il fascino intellettuale e politico di un uomo alle cui lezioni accorrevano numerosissimi, affascinati dall’eloquenza del suo dire, dalla libertà del suo pensiero e dalla profondità della sua scienza: giovani studenti di Lettere, ma anche di Ingegneria, di Medicina, di Giurisprudenza.
Con la scissione di Livorno del 1921 Concetto Marchesi aveva aderito al Partito Comunista d’Italia. L’andata al potere del fascismo e la successiva drastica limitazione delle libertà impongono a Marchesi un sostanziale abbandono della sua militanza politica. Egli non viene colpito da provvedimenti discriminatori e decide di prestare giuramento di fedeltà e lealtà al nuovo regime, quando ciò, nel 1931, diviene condizione per il mantenimento dell’insegnamento universitario. Di fatto però egli esercita un’enorme influenza spirituale e culturale sui giovani, che apprezzano, accanto alla sua enorme cultura scientifica, il richiamo a valori di libertà e responsabilità, individuali e collettive, che egli trasmette nelle sue lezioni e nei suoi scritti. Marchesi dunque attraversa il ventennio fascista relativamente appartato in un grande fervore di studi e in una esaltante funzione di maestro: sono testimonianza della sua ricerca le pubblicazioni, per l’epoca fondamentali, su Cicerone, Seneca, Petronio, Giovenale, Tacito, Marziale. Sulla sua Storia della Letteratura Latina, che esce in due volumi destinati agli studenti universitari nel 1925-27 e conosce una fortunatissima edizione ridotta per i Licei nel 1931 ( innumerevoli le riedizioni e ristampe) si formano- fino a tutti gli anni ‘60 del 900- generazioni di studenti.
Concetto Marchesi riemerge alla vita politica con l’acuirsi della crisi del regime fascista, che inizia a manifestarsi con l’andamento disastroso dell’avventura bellica in cui Mussolini aveva gettato l’Italia. Già nel 1942-43 egli allaccia rapporti con ambienti monarchico-liberali, in particolare con alte cariche dell’Esercito, cui propone la leale collaborazione dei Comunisti almeno in una azione comune tesa a far cadere Mussolini e a far uscire l’Italia da una guerra ormai insopportabile. In ciò egli agisce forte del suo prestigio intellettuale, ma non sempre le sue iniziative sono apprezzate dai dirigenti del PCI. Nei 45 giorni del Governo Badoglio il Ministro Leonardo Severi lo nomina Rettore dell’Università di Padova e- la cosa susciterà non poco scalpore, anche in ambienti comunisti- la carica, a metà Settembre del ‘43, gli viene confermata dal Ministro della neonata Repubblica Sociale Italiana, il fascista Carlo Alberto Biggini. Siamo agli albori della Repubblichina di Salò e Biggini appartiene alla schiera dei cosiddetti pacificatori: fascisti repubblicani che tentano di gettare un ponte agli oppositori del Regime proponendo una impossibile collaborazione per la salvezza d’Italia, collaborazione che quasi subito dimostra la sua impraticabilità a causa della presenza assolutamente egemone, sanguinosa e repressiva degli occupanti Tedeschi, cui di fatto anche i cosiddetti pacificatori sono completamente subordinati.
Sta di fatto che Concetto Marchesi rimane alla guida dell’Ateneo, e anche in questo il suo Partito gli manifesta ampie riserve- coadiuvato da un Prorettore notoriamente antifascista, il farmacologo azionista Egidio Meneghetti- nel duplice intento di preservare l’autonomia dell’università contro le prepotenze dei fascisti più estremisti e degli occupanti e di farne il centro della futura Resistenza. A Novembre Marchesi inaugura il 722° Anno Accademico con un celeberrimo discorso in cui sottolinea con forza l’importanza, per la rinascita del Paese, di una stretta unità fra le forze della cultura e quelle del lavoro, fra la gioventù studentesca e quella operaia e contadina. Ma soprattutto egli, dalla tribuna dell’Aula Magna del Bo, caccia insieme a Meneghetti un manipolo di studenti fascistissimi che intenderebbero trasformare la cerimonia dell’ apertura del’Anno Accademico in una ennesima manifestazione di sostegno alla guerra a fianco dei camerati tedeschi.
Comunque si giudichi l’azione di Marchesi nel breve periodo dell’autunno 1943 già a dicembre dello stesso anno egli giudica concluso il difficile tentativo di mantenere un’ ampia autonomia di pensiero e di opinione all’interno di un ateneo statale della repubblica fascista completamente asservita ai nazisti; il rettore lascia la carica, e nel suo famoso Appello agli Studenti ( del 1 Dicembre 1943 ) annuncia il suo passaggio alla macchia e incita apertamente i suoi giovani alla rivolta armata con un messaggio appassionato ed appassionante che avrà un effetto dirompente sulle scelte di parecchie centinaia di studenti e di docenti dell’università i quali compiranno fino in fondo, con grande valore e spirito di sacrificio, la scelta della lotta armata antifascista entrando numerosi, e spesso con funzioni di comando, nelle formazioni partigiane.
«Una generazione di uomini - scrive con passione Concetto Marchesi - ha distrutto la vostra giovinezza e la vostra Patria; vi ha gettato fra cumuli di rovine; voi dovete fra quelle rovine portare la luce di una fede, l’impeto dell’ azione e ricomporre la giovinezza e la Patria… Studenti: mi allontano da voi con la speranza di ritornare a voi maestro e compagno, dopo la fraternità di una lotta assieme combattuta. Per la fede che vi illumina, per lo sdegno che vi accende, non lasciate che l'oppressore disponga della vostra vita, fate risorgere i vostri battaglioni, liberate l'Italia dalla schiavitù e dall'ignominia, aggiungete al labaro della vostra università la gloria di una nuova più grande decorazione in questa battaglia suprema per la giustizia e per la pace nel mondo».
Concetto Marchesi passa clandestinamente la frontiera italo-svizzera e si trasferisce nella Confederazione, dove continua soprattutto attraverso la stampa la sua lotta contro il fascismo: il suo Appello agli Studenti verrà diffuso in migliaia di copie stampate clandestinamente in Italia. Diverse volte gli annunciatori di Radio Londra lo leggeranno ai tanti Italiani che clandestinamente e rischiosamente ascoltano nell’ Alta Italia occupata l’emittente alleata. Alla fine della guerra, per il suo massiccio impegno nella lotta di Liberazione, l’università di Padova verrà decorata di Medaglia d’Oro al Valor Militare.
Già alla fine del 1944 Marchesi rientrerà nell’Italia centro meridionale liberata dagli Alleati: con la rinascita della democrazia riprenderà intensamente la sua attività politica nel Partito comunista italiano; sarà membro della Consulta, eletto alla Costituente, deputato nella prima e seconda Legislatura. Nella città in cui tanta influenza ha esercitato sarà nominato Commissario straordinario dell’università , che vedrà poi Rettore il suo stretto collaboratore Egidio Meneghetti ( 1945-47). Concetto Marchesi muore a Roma nel 1957. A lui Padova ha intitolato un importante liceo.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








