Dentro la sinagoga oggi solo i fantasmi di corpi e preghiere
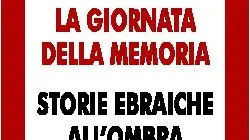
«Osservano le fiamme mentre bruciano tutto quello che non ci permettono più di essere, ma niente di questo ha importanza, pensiamo: è lo stesso». Pensano Anna e sua sorella dal loro rifugio di ricordi e racconti, mentre assistono inermi al rogo della loro casa e alla distruzione della loro famiglia, nascoste allo sguardo e alla furia delle truppe tedesche. Succede Vicino a Jedenew, romanzo d'esordio di Kevin Vennemann, ma succede anche vicino a noi, successe a Padova il 14 maggio 1943, quando una squadra fascista fece irruzione nella Sinagoga tedesca e la incendiò distruggendone la struttura lignea, gli arredi, il controsoffitto e il solaio e danneggiando l'intero edificio. Lì, però, ci fu chi non rimase a guardare e trasse in salvo i sefarim (i rotoli della legge) mentre il tempio bruciava; li estrasse dall'aron che pochi anni prima aveva visto le sue nozze con Ulda e che poco dopo avrebbe trovato asilo in Israele. In onore al padre e alla madre, Franco Sacerdoti ha voluto fare un personale "viaggio della memoria" per ritrovare quell'armadio sacro in marmi policromi che ora adorna una delle sinagoghe di Yad Eliahu, a Tel Aviv, e restituire alla Comunità con uno scatto e poche parole il gioiello della Scuola Grande. La Sinagoga tedesca ora è vuota e delle sue originarie funzioni religiose rimane solo un ricordo nell'iscrizione «Beth ha tefilà», ancora visibile sulla porta d'ingresso in via delle Piazze: «Casa della preghiera» è stata, e non solo, perché all'interno del Palazzo Antico Ghetto erano stati volutamente riuniti tutti i principali servizi comunitari quali un forno, un bagno rituale, una macelleria, un'aula di studio, nonché alcune botteghe al piano strada, delle cantine di sotto e delle abitazioni ai piani superiori. Casa della preghiera è stata prima per i soli ebrei ashkenaziti, e poi anche per gli italiani e i sefarditi, quando nel 1892 la Comunità deliberò che da quel momento ci si sarebbe riuniti tutti nella Scuola Grande per celebrare insieme lo stesso rito italiano. E Casa della preghiera non è più stata dopo l'incendio del '43. Distrutta dal fuoco e deteriorata dall'acqua, la sinagoga si presentava come un rudere fatiscente e pericolante, tamponato con i pochi mezzi rimasti dopo la guerra. Se però oggi è nuovamente riconoscibile come edificio di culto, con la sua facciata dai forti effetti cromatici tipici del barocco tedesco e il suo ampio salone luminoso, è grazie al senso di responsabilità che ha unito gli ebrei padovani allorquando l'assemblea degli iscritti, convocata a decidere la sorte del suo Tempio Maggiore, non poté nemmeno concepire la possibilità di alienare quel palazzo traboccante di storia. Così nel 1998, nonostante il notevole onere finanziario e il lungo iter burocratico, i restauri restituirono il Palazzo Antico Ghetto al suo originario splendore. Ancora troppo vuote, però, queste mura. Come un guscio dorato racchiudono solo un ricordo, non libri, non voci, non corpi, soltanto anime. Memoria, passato, ricordo,... rimbombano le parole nella grande sala fredda e vuota, quell'aula della Scola Grande, dove la luce rimbalza da una parete all'altra senza tregua, senza poter essere accolta da un parokhet, senza potersi posare su una pagina di preghiera. Eppure quella luce viene ancora oggi, come in passato, dalle cinque finestre della parete occidentale, che, come le cinque parti della Torah, vogliono alludere simbolicamente alla manifestazione della luce originaria. Ma quand'è che si manifesta sul serio quella luce? Quei dieci giorni l'anno, forse? In occasione di una festa o di un bar mitzvà, o per la Giornata Europea della Cultura Ebraica? Ancora un passo ci vorrebbe per ridare vita a queste mura. Affidate in gestione a una società specializzata prima e al Comune poi, non hanno avuto buona sorte. 150 posti e una sola entrata non fanno la fortuna di una sala polivalente; figuriamoci poi quando manca anche il parcheggio. E alla sala del midrash, a pianterreno, per un periodo precedente i restauri adibita anche ad autofficina, non è andata meglio. Oggi vi si ospita una mostra sui bambini nella guerra e nella Shoah. Che sia di monito, sì, come deve e vuole essere, ma che sia anche un segnale di speranza e di rinascita, una possibilità di riscatto.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova
Leggi anche
Video








