Il teatro comico nella Venezia del ’700
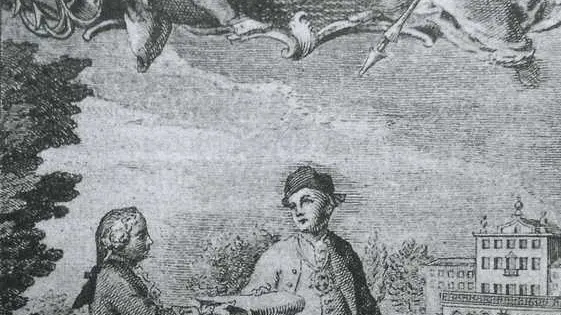
La Venezia dei teatri, soprattutto comici. È un affresco approfondito ma nello stesso tempo agile e inconsueto quello che un giovane e preparato studioso come Leonardo Mello dedica al Settecento teatrale veneziano, nel suo massimo splendore.
«Il Settecento veneziano - Il Teatro Comico», appena uscito per i tipi della Corbo e Fiore Editori, completa una collana dedicata al Secolo dei Lumi in laguna, dove si è già analizzata la letteratura (Bruno Rosada), la politica (Ivone Cacciavillani), la pittura (Filippo Pedrocco) e dove qui si pone appunto lo sguardo sulla vitalità della città dei sedici teatri in attività, non guardando solamente agli autori, ma anche agli attori protagonisti di questo momento felicissimo e al contesto in cui la vicenda teatrale veneziana era inserita, a cominciare dalla sua committenza.
«Offerta teatrale bulimica - ricorda non a caso Paolo Puppa nell’introduzione al volume, delineando il periodo - inaudita alla lettera, quasi il tifo da bar sportivo che oggi divide i “supporters” delle squadre di calcio, viene a crearsi grazie pure alle infinite querelles, alimentate dagli almanacchi, dalle gazzette, dai caffè, dalle epistole, dai manifesti che aprono ai diversi repertori». Nel suo saggio, Mello ricostruisce la “mappa” dei teatri veneziani dell’epoca, con particolare attenzione a quelli come il San Luca e il San Samuele, divenuti dei veri e propri “templi” della commedia. E non può fare a meno, naturalmente, di tracciare la parabola esistenziale e artistica di Carlo Goldoni, analizzando anche i contorni della sua celebre riforma, ma guardandolo anche in rapporto all’ostilità artistica e non solo, mossagli da avversari di rango tra cui ovviamente Carlo Gozzi e Pietro Chiari.
Ma lo sguardo si svolge anche al ruolo degli attori del tempo, soprattutto quelli capaci di “segnare” un ruolo o una caratterizzazione, come l’Antonio Sacchi-Truffaldino per il quale Goldoni scrive la prima versione del suo Arlecchino servitore di due padroni”. Ma non poteva mancare, in un testo che vuole offrire un panorama completo della scena teatrale veneziana settecentesca, anche, appunto, un’analisi della sua committenza, al ruolo di famiglie mobili come i Tron, i Vendramin e soprattutto i Grimani che spinti dalla molla del guadagno possibile, diventano veri e propri impresari. Di fronte a un atteggiamento saggio della Serenissima che, come scrive Mello, «controlla silenziosamente la moralità degli spettacoli», evitando di intervenire se non quando la violazione dei codici morali è palese. (e.t.)
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








