La sfida del clima e l’energia del sole nel Tour Innovazione in Veneto
La tappa padovana organizzata da Stampa e Mattino al Consorzio Rfx: il nuovo nucleare, il cuore bionico, i robot che svolgono i compiti ripetitivi e molto altro ancora

PADOVA. Il cuore e le stelle, l’energia del nostro corpo e quella dell’universo. Insieme diventano benzina di innovazione, in una sera in cui Padova ne è diventata capitale, entrando nel novero dei territori capaci di investire sul futuro, al termine del tour “Le sfide dell’innovazione” organizzato da La Stampa e dai quotidiani del gruppo Gedi.
E' qui che si realizzano robot in grado non solo di fare un salto mortale all’indietro ma anche di imparare l’esercizio, apprendendo dai propri errori. Qui si progettano gli ologrammi in sala operatoria, grazie alcardiochirurgo Gino Gerosa. Ma qui, soprattutto, si risponde alla vera emergenza del pianeta: la produzione di energia pulita. Con una sfida degna di Prometeo, mutuare la fusione del sole e delle stelle.
È ciò che si realizza nella grande struttura di Rfx, all’interno dell’area della ricerca in corso Stati Uniti. Da lontano il grande capannone bianco si confonde con il cielo latteo della zona industriale di Padova. All’interno però sembra un altoforno delle Acciaierie Venete (che infatti sono partner del progetto), tra carri trasportatori ed enormi cilindri.
Ma cosa accade davvero lì dentro? «Vogliamo riprodurre la reazione di fusione dell’idrogeno per produrre energia – semplifica Francesco Gnesotto, presidente del consorzio Rfx – Solo che quel processo dura un miliardo di anni, richiede una temperatura di 15 milioni di gradi e una massa enorme. Sulla terra la temperatura deve essere più alta, almeno 150 milioni di gradi, perché al posto della massa usiamo i campi magnetici».
Il reattore vero e proprio (che si chiama “Iter”) sarà in Francia. A Padova si svilupperà il sistema di riscaldamento per portare il plasma di idrogeno a quelle abnormi temperature, in modo da fondere e produrre elio. Nel capannone della Zip c’è la più grande sorgente al mondo di ioni negativi, che poi vengono neutralizzati per riscaldare il plasma.
Al contrario dell’energia nucleare qui non esistono scorie radioattive (al massimo c’è elio) e non esiste rischio di esplosione o incidenti. «Neppure se cadesse un aereo sulla centrale – chiarisce Gnesotto – Per questo le centrali a fusione saranno in grado di produrre una quantità di energia assolutamente controllabile e in modo concentrato, così da poter essere posizionate vicino alle città o alle aree industriali».
A Padova dunque si lavora a una risposta concreta alla preoccupazione di migliaia di studenti che chiedono un futuro migliore per il pianeta, a partire dal clima. «La linea a fusione è una sorta di assicurazione sul benessere nei nostri figli o nipoti, perché parliamo di un orizzonte temporale di 50-60 anni», risponde Gnesotto.
È la capacità di immaginare il futuro che caratterizza questo «visionario, scienziato, tecnico», come lo definisce sempre Molinari. «Bisogna essere convinti che l’importanza della sfida è tale da superare anche la frustrazione di non vedere i risultati immediati», racconta Gnesotto nell’unico momento in cui si lascia andare a una confessione personale.
Guardare lontano, sfidare i nostri limiti, imparare dagli errori: sono i segreti dei talenti dell’innovazione, raccontati nel viaggio targato Stampa e Gedi. «Queste energie positive trasmettono fiducia nel futuro», riflette Luca Ubaldeschi, coordinatore editoriale degli eventi del gruppo. «E i giornali diventano specchio del territorio, aiutandolo a costruire processi di consapevolezza», conclude il direttore del mattino di Padova Paolo Possamai.

“Fortuna che la fusione c’è e siamo leader”. A dirlo è Francesco Gnesotto, Presidente del Consorzio RFX di Padova.
Professor Gnesotto che cos’è il Consorzio RFX?
È un centro ricerche sulla fusione termonucleare, è nel programma europeo sulla fusione e nel progetto internazionale Iter, il reattore sperimentale in costruzione in Francia.
Cosa fa?
I nostri ricercatori stanno sperimentando come riprodurre il Sole in laboratorio per ottenere una nuova fonte di energia sostenibile con la fusione nucleare. Stiamo realizzando un prototipo dell’acceleratore di particelle neutre che servirà a portare alla temperatura di fusione il plasma di Iter, e una sorgente che avrà il compito di sparare un fascio di ioni negativi per scaldare il plasma del reattore fino a raggiungere 150 milioni di gradi. La potenza di dieci Soli!
Un progetto ambizioso
Sì, ma necessario per produrre energia pulita da fonti come l’acqua Iter è un progetto di Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Cina, India, Corea, Giappone. Insieme rappresentano il 50% della popolazione mondiale e l’80% del PIL mondiale.
Scopo di Iter?
Dimostrare definitivamente che la fusione è fattibile ed economicamente sostenibile. Dal punto di vista ambientale lo è, lo dice la fisica.
Quanto ci vorrà per realizzare il reattore vero e proprio?
Altre due generazioni di reattori: Iter e DEMO. Demo sarà una centrale elettrica vera e propria e dovrà dimostrare che si può produrre energia in gran quantità e con affidabilità.
Di chi sarà DEMO?
Dobbiamo aspetteranno i risultati di Iter per saperlo. Noi speriamo che l’Europa si convinca che bisogna investire nella fusione e così realizzi un suo rettore dimostrativo, DEMO appunto.
Costi?
Irrisorio, a mio parere. Nell’ordine dei 30/40 miliardi di euro: un giorno di consumi energetici nel mondo. L’Europa se lo può permettere.
E con la Brexit?
Iter non è in discussione. Ma la Gran Bretagna ospita JET, il reattore più grande al mondo per gli esperimenti di fusione, Deve ancora testare la sicurezza dei combustibili per realizzare la reazione di fusione. Con il ‘no-deal’ è quasi certo che JET chiuderà. Gli inglesi senza finanziamenti europei non riusciranno a gestirlo.
Quale lo stato della ricerca in Italia?
Per fortuna e per programmazione tutta la ricerca italiana sulla fusione è integrata in quella europea. Se l’Europa continua a investire nella fusione l’Europa, l’Italia andrà di pari passo.
L’Italia è un’eccellenza nel campo della fusione.
Lo è fin dagli anni ‘60 grazie ai gruppi universitari e poi a CNR ed ENEA. È settore in cui l’Italia è all’avanguardia, dentro a un’Europa molto avanti in questo campo. Iter del resto è in Europa, che paga il 45% del suo costo.
E l’Italia quanto investe?
Il 14% del programma quadro per la ricerca dell’EU. Qui c’è anche la fusione in l’Italia è leader. Il ritorno c’è: Frascati e Padova.
A Frascati c’è DTT.
Sì, una macchina della stessa linea di JET e Iter. È complementare a Iter ma non è comparabile con JET. Entrerà in funzione a fine 2025.
Costi e partner?
500 milioni di euro con un indotto sul territorio di circa 2 miliardi di euro.il progetto è di ENEA che sta costituendo un consorzio tra enti pubblici e privati. Probabile ci saranno anche CNR e INFN, soci del Consorzio, e alcune università.
Un progetto tutto italiano.
Con un finanziamento EU che arriverà nel prossimo Horizon Europe di 60 milioni di euro.
E la ricerca italiana in generale?
Investiamo troppo poco. Con l’1,5 l’Italia si allontana dai paesi sviluppati.
Quindi fortuna che la fusione c’è?
Sì, purtroppo però è solo un piccolo tassello nel panorama generale della ricerca italiana.
IL CUORE BIONICO
«L’impossibile di oggi sarà il possibile di domani», dice Gino Gerosa, uno dei massimi cardiochirurghi al mondo che proprio qui a Padova sta realizzando il progetto di un cuore bionico. Gerosa cattura e incanta alle “Sfide dell’innovazione”.
Il trapianto di cuore resta la migliore risposta terapeutica per i pazienti affetti da insufficienza cardiaca irreversibile, che non riescono più a rispondere alle terapie mediche o a interventi tradizionali. Il problema è che non ci sono abbastanza cuori per i pazienti che ne hanno bisogno.
Per fortuna ci vengono in aiuto le tecnologie. I Vad, ad esempio, sono sistemi di assistenza ventricolare che si usano nei casi di insufficienza cardiaca irreversibile e posso sostituire la funzione del ventricolo o del cuore artificiale totale.
«La differenza rispetto all’uso di cuore artificiale sta nel fatto che con il Vad il cuore resta in sede, viene inserita una pompa a flusso continuo che aiuta il ventricolo nella sua funzione di veicolare il sangue in aorta», spiega Gerosa. Padova è sempre stata all’avanguardia in questo settore: nel 1985 il professor Vincenzo Gallucci eseguì il primo trapianto di cuore umano e nel 2007 Gerosa e la sua équipe hanno eseguito il primo trapianto di cuore artificiale totale. Il numero di trapianti è diminuito in modo significativo perché sono state modificate alcune leggi dello Stato.
Negli anni Ottanta l’età media del donatore era di 18 anni, oggi è intorno ai 55. La legge sul casco ha diminuito i casi di morte cerebrale e oggi il donatore è un adulto di mezza età che muore per morte cerebrale non post traumatica, ma per ischemia o per emorragia cerebrale. Se non non ci sono danni a organi come fegato, polmoni o reni allora il cuore di questo adulto può esser un buon candidato per una donazione.
«Il numero di donatori è aumentato, certo», afferma Gerosa. «L’Italia è al primo posto per donazioni per milione di abitanti. Ma il profilo clinico del donatore è peggiorato in maniera significativa quanto allo stato di salute del cuore. Ecco perché la risposta migliore sono sistemi di assistenza meccanica».
L’età media della cardiochirurgia si è alzata. Ci sono più pazienti anziani che arrivano all’intervento cardiochirurgo. «Le nuove tecnologie ci permettono di eseguire interventi meno aggressivi, usando sistemi di imaging che permettono di guardare all’interno delle cavità del cuore, intervenire in modo meno invasivo e garantire un più veloce recupero delle funzioni corporee».
Straordinaria è la tecnologia che entra in sala operatoria. «Questo è un momento eccitante per la cardiochirurgia», afferma entusiasta Gerosa. «È l’era della cardiochirurgia micro invasiva che permette di utilizzare piccoli accessi per arrivare al cuore, riuscendo a operare senza circolazione extracorporea e senza fermare il cuore». Un bel balzo in avanti.
«L’innovazione è una sfida, che deve essere accolta, guardando a se stessi ma pure agli strumenti che ne permettano una vera diffusione». A dirlo Francesco Nalini, a.d. della padovana Carel, gruppo internazionale da oltre da 280 milioni di euro di fatturato che investe in innovazione ogni anno circa il 6% de proprio fatturato.
Ma per Nalini, ospite assieme a Antonella Candiotto general manager di Galdi, Massimo Canducci direttore dell’ufficio innovazione del colosso Engineering e Renzo Simonato, direttore per il Triveneto di Intesa Sanpaolo dell’evento “Le sfide dell’Innovazione”, la diffusione delle tecnologie è uno dei nodi centrali dell’innovazione.
«La vera forza delle applicazioni tecnologiche» ha detto l’a.d. di Carel «sta nella loro penetrazione negli usi delle imprese e dei loro clienti, a tutti i livelli. Noi investimento molto in ricerca e molto in innovazione di processo. Ma per rendere questi investimenti produttivi dobbiamo guardare alla formazione interna come il sistema deve poter fare sul suo tessuto economico e culturale di riferimento».
Esempio calzante di diffusione della tecnologia sta nella storia della trevigiana Galdi, circa 20 milioni di euro di fatturato annuo e la forza di affrontare una sfida capace di portare una Pmi del territorio ad offrire sul mercato internazionale delle macchine per il packaging soluzioni tra le più innovative sia in ambito Iot che di sostenibilità.
«Per noi l’innovazione è Dna dalla nascita» ha raccontato Candiotto anche vicepresidente di Assindustria Venetocentro. «Mio padre, il fondatore dell’azienda, era un genio innovatore e noi abbiamo cercato di raccogliere il suo testimone creando un team che sapesse guardare a un tessuto capace di fornirci quanto ci serviva per la nostra sfida. Con il supporto di un sistema confindustriale che ha saputo organizzarsi per dare risposta alle esigenze delle sue Pmi, abbiamo guardato alle università venete, al dipartimento di Ingegneria di Padova, e ai parchi scientifici del territorio. Con la collaborazione di tutti abbiamo raggiunto i nostri obiettivi e guardiamo al futuro con fiducia».
Ma l’innovazione di processo non prescinde da quei servizi digitali, che vede nella padovana Engineering, un punto di riferimento globale.
«Siamo nati 39 anni fa come costola tecnologica di Cerved» ha ricordato Massimo Canducci, chief innovation officer di Engineering «e abbiamo colto l’opportunità di offrire gli stessi servizi su un mercato che ha apprezzato la proposta. Ora a Padova abbiamo un centro di competenza che si occupa di big data, un’area tecnologica strategica per il futuro come l’intelligenza artificiale».
Una rivoluzione che ha investito da tempo anche il sistema bancario come ha ricordato il direttore Nordest di Intesa Sanpaolo, Renzo Simonato. «Automazione degli sportelli, riorganizzazione dei processi, digitalizzazione dei documenti, ma pure algoritmi predittivi sono all’ordine del giorno di una banca che è al centro di un territorio innovativo e che deve confrontarsi con le esigenze di un sistema economico e di una popolazione che cambia».
IL TOUR DEGLI IMPIANTI
Molta curiosità e attenzione. D’altronde vedere da vicino come si può arrivare a produrre energia pulita, pulitissima, attraverso la fusione termonucleare controllata non è cosa da tutti i giorni. Emulare il processo del sole ma a temperature dieci volte superiori a quelle del suo nucleo. È innovazione anche solo pensarlo. E invece sta già succedendo.
Questo il tema al centro delle visite organizzate dai nostri quotidiani e da La Stampa al Consorzio Rfx di Padova. Dove, proprio in questi giorni, si sta sperimentando il prototipo dell’acceleratore di particelle neutre che servirà a portare alla temperatura di fusione il plasma del reattore sperimentale in costruzione in Francia. La sfida coinvolge la comunità scientifica internazionale che aderisce al programma europeo sulla fusione e al progetto Iter. Affacciarsi sul prototipo Spider del consorzio Rfx è stato un motivo di richiamo. Il Consorzio Rfx opera all’interno del programma europeo sulla fusione e del progetto internazionale Iter, è tra i centri di eccellenza a livello mondiale in questo settore e ha tra i soci Cnr, Enea, Infn, Università di Padova, Acciaierie Venete Spa.
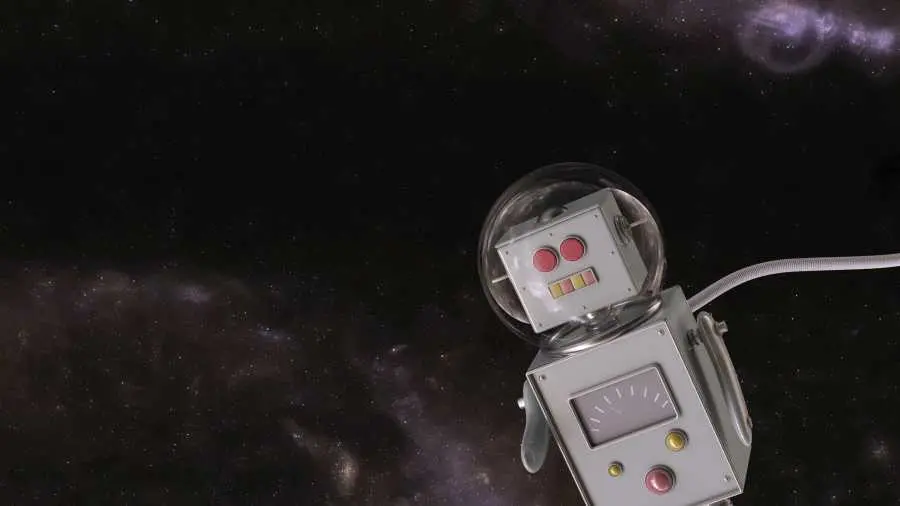
In vista della tappa veneta del tour innovazione, abbiamo costruito una serie di servizi sull'innovazione di territorio, dall'impegno delle università a quello del mondo delle imprese. E poi la ricerca Eumetra sul rapporto tra cittadini e nuove tecnologie, oltre alle eccellenze sul territorio.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








