Il Veneto dei dialetti e i dialetti d’Italia: siamo tutti minoranza
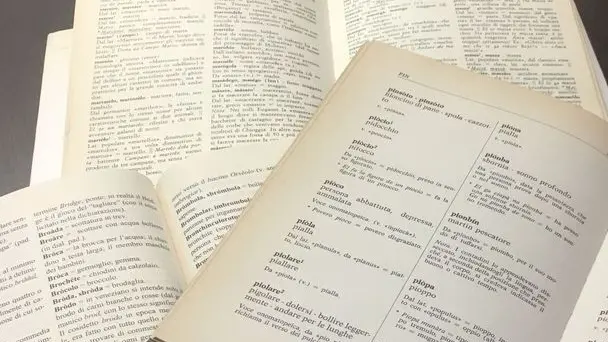
Ragiono sulla legge regionale che definisce il popolo veneto una minoranza nazionale a partire dai resoconti giornalistici, dato che non mi risulta che il testo ufficiale sia stato ancora pubblicato.
Lo faccio soprattutto dal mio punto di vista di linguista, punto di vista primario per gli stessi proponenti, se è vero che il consigliere leghista Barbisan ha fatto riferimento, mostrando di considerarlo il centro della legge, all’obiettivo di «difendere la cultura e la lingua veneta come testimonianza viva dell’identità del nostro popolo».
Sul piano dei principi, chi ha proposto e approvato la legge può portare buone argomentazioni: dal punto di vista linguistico non c’è differenza tra quelle che sono definite lingue e quelli che sono definiti dialetti, e la determinazione di quale dialetto possa essere considerato lingua dipende da fattori storici e culturali che vengono alla fine sanciti da una decisione politica. È noto l’aforisma, attribuibile a Max Weinreich: «una lingua è un dialetto con un esercito e una marina».
È una definizione che, con un’immagine pittoresca, anche se per molte realtà inesatta, vuole proprio marcare il carattere extralinguistico dell’attribuzione a un sistema linguistico del carattere di lingua. Così, il friulano e il sardo possono vantare lo status di lingua perché sono etichettati come tali dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, non per altri meriti.
La legge veneta appena approvata pare viziata dal fatto che la decisione sullo status di una lingua non può essere di competenza regionale. Prescindendo da questo, pur fondamentale, aspetto giuridico, i Veneti possono comunque ben rivendicare il carattere di lingua della propria parlata, ma a un patto: quello di riconoscere lo stesso diritto a tutti i cittadini italiani, ai Lucani come ai Molisani, ai Toscani come ai Liguri.
Non c’è nessun motivo per dare l’etichetta di lingua al veneto, e non a uno qualunque degli altri dialetti (con il risultato, paradossale, che non ci sarebbero più minoranze nazionali in Italia, per la mancanza di una maggioranza a cui contrapporsi). Ma occorre, anche, disconoscere lo sviluppo linguistico dell’ultimo secolo e mezzo, che ha visto l’italiano diventare lingua materna, sempre più liberamente condivisa, degli Italiani di tutte le aree del Paese.
Resta certamente il fatto che nell’Italia nord-orientale persiste, secondo un’indagine Istat del 2012 pubblicata nel 2014, un ampio uso del dialetto, sia in famiglia che con gli estranei, inferiore, però, nel suo complesso, a quello dell’Italia meridionale (purtroppo da questa indagine non riesco a ricavare suddivisioni più fini: in genere il Veneto presenta percentuali di uso del dialetto, soprattutto con gli estranei, superiori a quelli di tutte le altre aree del Paese).
Tutto questo dà sufficienti motivazioni per inserire il veneto nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni? È opportuno farlo? Ci sono le condizioni pratiche per farlo? Ricordiamoci che il veneto continua ad essere vitale, pure in situazioni comunicative di media formalità, anche se non è mai stato lingua veicolare ufficiale nelle scuole della regione.
L’uso del veneto nelle scuole e nell’amministrazione ha dentro di sé una componente potenzialmente autodistruttiva: quella della codificazione (cioè l’individuazione di una norma unitaria). Senza un’accorta tolleranza verso tutte le varietà, è un problema destinato a riprodurre a livello locale la lotta tra le varietà egemoniche e quelle secondarie.
Per negare che il veneto sia una lingua, molti portano l’argomento che il padovano è diverso dal veronese, il bellunese dal veneziano, e via dicendo. In sé, non si tratta, a mio modo di vedere, di un’obiezione di forte peso: i dialetti veneti hanno un consistente fondo comune, anche nel vocabolario, sul quale si innestano indubbie differenze fono-morfologiche e lessicali: ma questo non impedisce una quasi completa mutua comprensione e il riconoscimento di appartenere alla stessa comunità regionale.
Il problema si porrebbe, però, inevitabilmente nel momento in cui, ad esempio, il Consiglio Regionale dovesse produrre le sue leggi oltre che in italiano, in veneto: quale veneto sarebbe il veneto di fatto ufficiale? Quello con il maggior numero di parlanti, il veneto centrale (vicentino, padovano, rovigoto)? Quello del capoluogo amministrativo, ma anche culturale, il veneziano? Quello più arcaico? Quello del proponente, con il risultato che le leggi (e anche gli emendamenti?) verrebbero scritte in varietà diverse?
Temo che il riconoscimento del veneto come lingua ufficiale sarebbe più esiziale, per la sua conservazione, dell’attuale stato di sostanziale libertà linguistica.
Come ho sentito dire una volta, tantissimi anni fa, ad Andrea Zanzotto: «non condanniamo il dialetto al triste destino di diventare lingua». Ne va della sua vita, mi viene da aggiungere.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








