Pietro Fortunato Calvi il sogno rivoluzionario di un patriota veneto
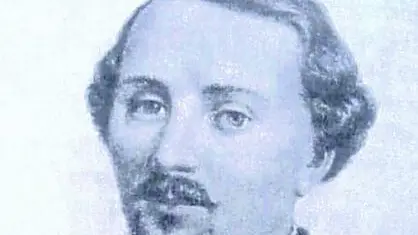
di Filippo Tosatto
Qualche anno dopo, salendo i gradini del patibolo, Pietro Fortunato Calvi avrebbe ripensato con orgoglio e tristezza a quei giorni esaltanti. I patrioti che sfidavano l’Impero, gli ideali libertari sulla punta delle baionette, la “meglio gioventù” d’Italia irriducibile al tallone dell’alleanza di trono e altare. Tutto sembrava svanito con le forche di Belfiore; tutto stava per deflagrare nella “primavera dei popoli” di metà Ottocento.
Un’esistenza breve e senza tregua, la sua, iniziata il 15 febbraio 1817 a Briana di Noale, lembo del Veneziano all’epoca in provincia di Padova. La devota madre Angela Meneghetti, il padre Federico Pietro commissario di polizia, l’educazione cattolica, l’ossequio alla corona d’Asburgo sovrana del Lombardo-Veneto. E il trasferimento nella città del Santo, gli studi al ginnasio “Santo Stefano” (l’attuale Tito Livio), l’ammissione all’esclusiva “Accademia militare degli ingegneri “di Vienna. Sei anni dopo - è il 1836 - il giovane esordisce nell’esercito d’Austria e Ungheria: alfiere, tenente, primo tenente con destinazione Venezia. È avviato ad una carriera brillante, con gli agi e il prestigio sociale riservati ai sudditi fedeli, ma il contatto con i circoli patriottici e la coscienza della “gerarchia diseguale” imposta dagli occupanti, incrina presto il suo lealismo suscitando i sospetti del comando, che lo trasferisce alla guarnigione di Graz.
Troppo tardi. Nell’aprile del fatidico 1848 Pier Calvi abbandona la divisa, rompe con il passato, raggiunge la laguna insorta: diventa capitano della Repubblica di San Marco e Daniele Manin lo invia in Cadore, porta d’accesso degli austriaci al Veneto. Qui, alla testa di quattromila volontari improvvisati (molti sono volonterosi contadini “armati” di falci e sassi) adotta la tattica della guerriglia e, contro ogni previsione, scaccia il nemico dalla Valle del Boite, sconfigge le truppe del generale Karl von Culoz a Rivalgo di Ospitale di Cadore, strappa nuovi successi a Rindemera e presso la Chiusa di Venas di Cadore. Ma è una battaglia impari: il 15 giugno, incalzato da ogni parte, l’ufficiale congeda la milizia e si rifugia in laguna dove partecipa all’estrema, vana, resistenza alla restaurazione.
Tempo di esilio, dalla Grecia a Torino, dove Calvi vive in miseria, bollato come traditore dal suo stesso padre. Nella capitale subalpina, però, l’esule incontra Giuseppe Mazzini e l’ungherese Lajos Kossuth e il sodalizio con gli ideologi del risorgimento europeo trasforma il ribelle in rivoluzionario, cambiando il suo destino.
Non più pago di sostituire l’aquila imperiale con lo stemma sabaudo - secondo il programma liberal-moderato - il veneto si converte alla causa democratica e repubblicana che alla liberazione della patria dallo straniero abbina la fine del dominio monarchico e l’ingresso dei ceti popolari (le “ingrate plebi” emarginate da chi appartiene all’“aristocrazia per nascita o per denaro”) nella vita nazionale. Un disegno pericoloso, scandito dal ritorno in terra cadorina, stavolta per volere di Mazzini che sogna l’insurrezione dei montanari.
L’impresa, complice un tradimento, finisce con l’arresto dell’intero commando (è il 17 marzo 1853) a Cogolo in Val di Sole. Le armi e i passaporti falsi non lasciano scampo: sottoposto a pestaggi e torture, Calvi assume ogni responsabilità nel tentativo (riuscito) di evitare il capestro ai cinque compagni. E al processo marziale di Mantova, rivendica la scelta della resistenza armata con accenti di sfida che un secolo dopo riecheggeranno nella replica di Sandro Pertini («Siete voi un partigiano?», «No, io sono un comandante partigiano») al Tribunale speciale fascista.
Giudicato colpevole di alto tradimento, Pier Fortunato Calvi sarà impiccato il 4 luglio 1855.
Una vicenda, la sua, destinata a larga fortuna nella storiografia e nell’iconografia successiva all’Unità, inclini tanto ad esaltarne le doti umane di generosità e coraggio quanto a sottacerne la radicalità politica e sociale alternativa al moderatismo cavouriano dei vincitori. Non stupisce allora che a molti anni di distanza (correva il 1892) il “radicalsocialista” Giosuè Carducci dedichi al combattente l’Ode “Cadore”, dove il cedimento alla retorica («Io vo’ rapirti, Cadore, l’anima/ di Pietro Calvi; per la penisola/ io voglio su l’ali del canto/ aralda mandarla») non offusca l’onore delle armi al limpido resistente del quale oggi, nel silenzio distratto di un Paese che dimentica storia e memoria, ricorre il bicentenario.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








