Padova vince la sfida del rubinetto in Italia
Le analisi dell'Arpav confermano il giudizio positivo: i nitrati unico punto debole. Acquedotto Aps: da due anni i consumi stabilizzati a 42 milioni di metri cubi
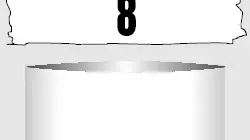
Quella che esce dai rubinetti delle nostre case è lo champagne delle acque d'Italia. Questa inchiesta del mattino di Padova vuole offrire ai lettori informazioni precise sulla qualità dell'acqua proprio nel periodo della grande sete e in una congiuntura meteorologica particolare, soggetta a salienti variazioni climatiche che potrebbero mettere a rischio l'erogazione di un bene estremamente prezioso.
Il campione prelevato dall'Arpav il 18 luglio scorso (dati in tabella) ci consente anche un raffronto con il servizio pubblicato da «La Repubblica» mercoledì scorso intitolato «I voti all'acqua che beviamo». L'articolo del quotidiano nazionale analizza goccia a goccia l'acqua potabile di 9 grandi città italiane (la durezza, il Ph, i nitrati, l'ammonio, il cloro residuo) e promuove i rubinetti del Belpaese con un verdetto di potabilità che, sempre accettabile, varia da un capoluogo all'altro. La classifica acquedottistica mette in fila Milano, Torino, Bologna, Genova, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo (vedi tabella in alto).
I voti sono compresi dal 6 di Napoli e Palermo al 7,5 di Roma, capitale dell'acqua buona. Se inseriamo Padova in questa classifica le dobbiamo dare 8, anzi 8 e mezzo: così dicono gli esperti. Come si attribuisce questo voto? L'unico punto debole dell'acqua padovana sono i nitrati: 17. Il limite legale oltre il quale l'acqua non è potable è 50. Si tratta di una quantitativo abbastanza rilevante che dipende dall'azoto fertilizzante in un'area ad alta concentrazione zootecnica. Per cui per via dei nitrati quest'acqua si meriterebbe un 6,5 ma a bilanciare la «falla» c'è il fatto che l'acqua di falda che sgorga dai pozzi e poi viene incanalata nella rete è oligominerale, tale e quale quella imbottigliata e per questo si meriterebbe 10. Ecco, quindi, le ragioni dell'8,5. E non crediamo di sbilanciarci eccessivamente né di peccare di campanilismo idrico.
Il territorio della provincia di Padova ha un'estensione di 2141,6 chilometri quadrati con una popolazione di 890.805 abitanti. Si tratta di una zona abbondantemente intrisa di corsi d'acqua, Brenta e Bacchiglione i fiumi principali, ma notevole importanza riveste la presenza di risorgive dove l'acqua sprizza limpida dal terreno. L'acquedotto di Padova, gestito da Acegas-Aps pesca proprio in quest'area. Sono i pozzi di Villaverla, Dueville, Caldogno, Monticello Monte Otto. In queste falde l'acqua impiega parecchi anni prima di arrivare alle fonti di attingimento. Durante il lento processo di filtrazione il liquido si libera di sostanze in sospensione e di batteri e si arricchisce di anidride carbonica e di sali minerali. Questo fenomeno di alchimia naturale si ripete, sempre uguale, da migliaia di anni. E' come un grande materasso d'acqua che si è accumulata e si rinnova con il fluire di rivoli dall'area pedemontana. La pianura galleggia su un giacimento di acqua sotterranea che, a tratti, affiora in pozzi tra il verde; fauna e flora segnano la salubrità ambientale della zona: il martin pescatore, il pesce marsone, la libellula sono le creature totemiche del luogo.
Legambiente, in un dossier-acqua pubblicato nel marzo scorso rileva: «Nel corso del 2006 nel Padovano i laboratori di Arpa Veneto hanno effettuato 22.500 controlli senza riscontrare per tutti i Comuni della provincia alcun superamento dei limiti di legge, anzi le acque di rete qui distribuite non differiscono sostanzialmente dalle acque imbottigliate per il consumo quotidiano della popolazione. Basti pensare che acque minerali con l'etichetta Guizza, Vera e altre succhiano acqua nello stesso areale. E, tuttavia, malgrado la pubblicità che Aps non ha mancato di fare (le bollette sono accompagnate da una scheda con la composizione dell'acqua come le etichette delle bottglie di minerale) il consumo è sempre lo stesso: 42 milioni di metri cubi l'anno nel 2005 e 2006.
Il che significa che la città, confermando la generale tendenza del Paese, resta una grande consumatrice di acqua imbottigliata. Il dossier di Legambiente dice che un metro cubo di acqua potabile costa in media tra 0,51 e 1,08 euro mentre una bottiglia di acqua minerale contenente 1,5 litri può costare tra i 20 e i 50 centesimi di euro. Considerando che un metro cubo corriponde a mille litri, è facile rendersi conto della sproporzione tra i costi. L'acqua in bottiglia costa dalle 400 alle 700 e spesso anche 1000 volte di più. A questi costi vanno aggiunti quelli di smaltimento delle bottiglie vuote. Se ogni italiano consuma 172 litri di acqua minerale in un anno, tale quantità equivale a 90 bottiglie di plastica e a una trentina di vetro che moltiplicate per 55 milioni di italiani fanno quasi 5 miliardi di bottiglie di plastica da smaltire l'anno. Tenendo conto che la raccolta differenziata della plastica ne intercetta il 20 per cento circa, almeno 4 miliardi di bottiglie finiscono in discarica. Ogni anno bere ci costa circa 1 milione di metri cubi di discariche.
E veniamo agli sprechi. Oggi l'acqua del rubinetto a cui si preferisce quella in bottiglia viene sprecata. Aps ha diffuso informazioni precise antispreco via Internet e attraverso riviste e fatture: un rubinetto che gocciola può sprecare fino a 10 litri di acqua al giorno, uno sciacquone del water oltre 100 litri. Per fare una doccia si utilizzano mediamente 80 litri d'acqua, per il bagno ce ne vogliono 150/200. Se lavi l'automobile con la pompa consumi fino a 200 litri d'acqua, se usi un secchio ne risparmi 130 litri ad ogni lavaggio. E ricordiamoci che è sempre acqua potabile, anche quella usata per annaffiare il giardino. Tenere aperto il rubinetto mentre ci si lava i denti o ci si rade equivale a buttare via 2500 litri d'acqua all'anno.
Via Vincenzo Stefano Breda, da via Santa Lucia verso le piazze. Sotto c'è scritto benefattore. Ma Breda fu un grande ingegnere, un imprenditore sagace, un politico, un grande presidente della Camera di Commercio. Ma «benefattore» va bene. Fu Breda, nei primi anni del Novecento, a realizzare il primo raccondo tra Villaverla e Padova, un nastro d'acqua pulita per alimentare la città. Prima si attingeva ai pozzi o al fiume e ogni anno si moriva di febbre tifoidea, vere e proprie epidemie. L'acqua di Breda diede salute alla città e creò la premessa per una grande infrastruttura che funziona bene anche oggi. Il link originale era una canaletta a cielo aperto che fu poi affiancata da una condotta in cemento e più tardi da un tubo d'acciaio da 1200 millimetri.
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova
Leggi anche
Video








