Uno non vale uno: ecco la democrazia diretta e altri miti d’oggi
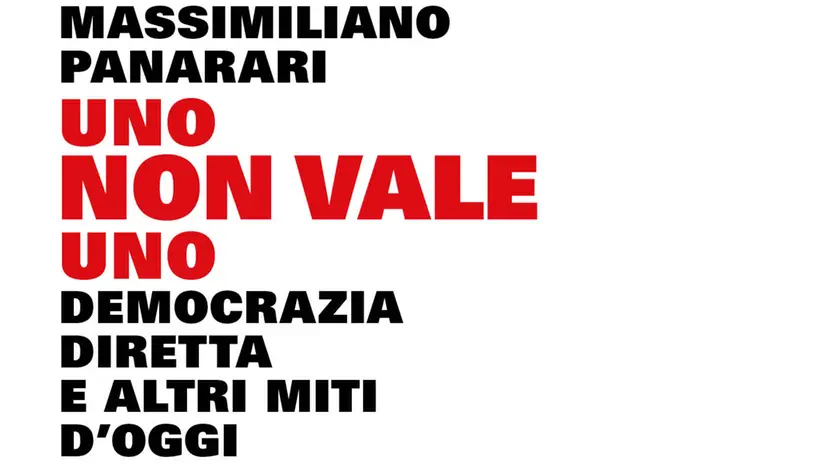
Uno non vale uno: davvero? Sbaglia, Massimiliano Panarari, che in un saggio appena pubblicato da Marsilio sfida lo spirito del tempo, la logica politica mainstream e pure l’algebra. Uno vale uno: semplice, lapalissiano, incontrovertibile. Ce la mette tutta, l’autore, per fare il debunking delle narrazioni “pop-sov” (populiste e sovraniste) e dei loro miti. Ma così è, così deve essere: 1 = 1. (NB: per farsi un’idea compiuta sul libro, leggere fino in fondo)
Lo stabilisce la democrazia e persino la costituzione italiana, come ha di recente ricordato il premier Conte: la sovranità appartiene al popolo. Punto. Non serve nemmeno essere dei giuristi, per saperlo. Non serve nemmeno proseguire, nella lettura della “carta”, anche perché scopriremmo che il potere va esercitato nei limiti stabiliti dalla costituzione, che allo stesso tempo stabilisce una serie di pesi e contrappesi.
E prevede una serie di corpi intermedi. Vade retro: mediare significa, inevitabilmente, deviare rispetto a una volontà che deve fluire, direttamente, dal popolo. Diffidate di qualsiasi (sedicente) rappresentante. Se non è già un membro della casta, verrà di certo corrotto dal potere. Basta con i privilegi: uno vale uno. Me generation Sbaglia, quindi,
Panarari, che pure, in 160 pagine ottimamente scritte (e pure divertenti), chiama a raccolta, in maniera rigorosa, il meglio della filosofia, della sociologia, della scienza politica. E individua fin dai primi paragrafi la radice delle trasformazioni analizzate: l’avvento della me generation, l’assoluto primato dell’individuo all’interno della società contemporanea. Un processo di lunga durata, ma che accelera e arriva a compimento a partire dagli anni Settanta: dalla febbre del sabato sera fino all’esercito del selfie del nuovo Millennio. Da specialista dei mass media,
Panarari ricostruisce in modo preciso questa metamorfosi. E arriva a isolare il format definitivo: quello del reality, che cancella la distinzione tra uomo della strada e gli “eletti”. Nessuna gavetta per entrare nello star system, nessun cursus honorum per scalare il sistema politico.
È l’epoca dell’autenticità e del totale rispecchiamento, che nel passaggio dalla (neo)televisione alla Rete raggiunge la massima espressione. Neorealitysmo, è il neologismo suggerito dal libro: Tú sí que vales. Sbaglia due volte, allora,
Panarari – che queste cose le insegna all’Università e (aggravante) è pure un po’giornalaio – a voler portare i propri titoli e la propria lunga competenza a sostegno di una tesi tanto bislacca. Uno non vale uno?
«Questo lo dice lei», Professore. Nell’epoca dell’assoluta orizzontalità, siamo finalmente tutti sullo stesso piano: il virologo twitstar e il @nickname qualunque; «quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare» ma postano in maniera compulsiva il loro astio di (ex? ) perdenti. Chi ha studiato non deve avere per forza ragione, ha ammonito di recente la cittadina-vice-ministro Laura Castelli. Difficile darle torto.
Ogni opinione ha la stessa dignità: deve poter essere espressa, e pesare quanto le altre. Alla ghigliottina ogni autoritarismo scientifico. Uno vale uno. Anzi, uno vale l’altro. Viva quindi la democrazia! Ma nella sua interpretazione letterale, che annulla ogni distinzione tra titolarità ed esercizio del potere.
Viva la democrazia nella sua forma diretta, che permette ad ogni cittadino – uno vale uno – di decidere direttamente, senza rappresentanti e senza mediazioni. Attraverso i referendum e attraverso la rete. Poco importa se tali decisioni possono trascinare un paese nel caos, come sta avvenendo con la Brexit. Poco importa se, in questo modo, viene a crearsi lo spazio per nuovi mediatori. Di più: veri e propri super-mediatori. Siano essi i FANGA (Facebook, Amazon, Netfilx, Google, Apple).
O i tanti aspiranti uomini forti, alla guida di altrettante formazioni personali, che plasmano il proprio partito-azienda (e a volte anche le istituzioni) attorno alla propria persona: perché Io valgo… uno. Se tutti gli altri valgono zero (o giù di lì). Il “noi” fittizio Allora forse un po’ di ragione ce l’ha,
Panarari, quando scrive che il popolo è una fictio (n): una “comunità immaginata”. Un Noi ancor più fittizio – instabile, intermittente, inafferrabile – rispetto ai Noi del passato. Cui si aggrappano tanti Io, sempre più disorientati, impauriti e arrabbiati. Da qui emergono i tanti “prima gli americani”, “prima gli italiani”, “prima gli svizzeri”… dietro i quali si intravede solo un grande Me First. PS: A scanso di equivoci, il libro è bello, in molti passaggi illuminante. È la mia opinione, e vale uno. (Fabio Bordignon)
Il mito odierno dell’autenticità (tratto dal libro)
La Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti promulgata il 4 luglio del 1776, nel suo preambolo, come si sa, proclama il «diritto al perseguimento della felicità».
Un diritto inalienabile secondo i padri fondatori che si ribellarono alla corona britannica, al punto da collocarlo accanto ai diritti alla vita e alla libertà.
Un’intuizione che piaceva molto anche a Gaetano Filangieri, il giurista e filosofo esponente dell’alquanto geolocalizzato Illuminismo napoletano, il quale, nel 1780, nella sua opera più famosa, La Scienza della Legislazione, indicava il «progredire della felicità nazionale» – da intendersi in maniera molto specifica e circostanziata nei termini della «somma di felicità dei singoli individui» – come l’autentica e suprema finalità del governo.
Passati questi entusiasmi illuministici, le carte costituzionali contemporanee – come la nostra – si sono mostrate decisamente più parche e frugali nel riconoscimento di un diritto la cui fruizione risulta tanto intima e privata e, sotto svariati profili, inafferrabile. E, dunque, se non esiste un diritto relativo al conseguimento di quella materia così anelata ma sfuggente che è la felicità, figuriamoci se in Costituzione può venire contemplato un “diritto al rutto” o un “diritto all’insulto” – e, analogamente, non esiste un diritto all’eruttare le fake news come se fossero “verità vera” (o, per dirla come Bannon e gli spin doctor trumpisti, “verità alternativa”).
Passati questi entusiasmi illuministici, le Carte costituzionali contemporanee – come la nostra – si sono mostrate decisamente più parche e frugali nel riconoscimento di un diritto la cui fruizione risulta tanto intima e privata e, sotto svariati profili, inafferrabile.
E, dunque, se non esiste un diritto relativo al conseguimento di quella materia così anelata ma sfuggente che è la felicità, figuriamoci se in costituzione può venire contemplato un “diritto al rutto” o un “diritto all’insulto” – e, analogamente, non esiste un diritto all’eruttare fake news come fossero “verità vera” (o, per dirla come Bannon e gli spin doctor trumpisti, «verità alternativa»).
Eppure è proprio questa la seconda mitologia che accompagna e sorregge la democrazia in salsa populista: quella del diritto a rivendicare in politica la cosiddetta «sincerità-veracità» e una presunta schiettezza. E che si manifesta nell’esaltazione dell’assenza di mediazioni in qualunque ambito della vita associata, nessuno escluso.
Disintermediazione à gogo, quindi, compresi i rapporti con gli oppositori politici, con i quali si deve andare al sodo, al corpo a corpo, aggredendo verbalmente l’avversario (meglio, «il nemico»), offendendolo, denigrandolo, e magari facendo pure killeraggio a colpi di dossier o di «squadrismo mediatico», inclusa la forma soft del gossip su qualche rotocalco rosa.
Una rivendicazione di «vere verità» che corrisponderebbe al saltare e bypassare gli inutili orpelli del formalismo caratteristici della dialettica politica della democrazia formale. E permetterebbe, in tal modo, di avvicinarsi giustappunto, una volta di più, alla sana e benedetta disintermediazione, rispondendo appieno a quella voglia popolare di autenticità che attraversa come un’istanza irresistibile e irrefrenabile l’età della democrazia del pubblico.
In virtù di uno dei primissimi paradossi postmoderni, la dilatazione ed espansione dell’ego e l’aspirazione all’autorealizzazione di sé sono andate a braccetto con una sempre più spasmodica ricerca di ciò che è autentico.
Massimiliano Panarari, Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi
Marsilio (pp. 160, euro 12)
Riproduzione riservata © Il Mattino di Padova








